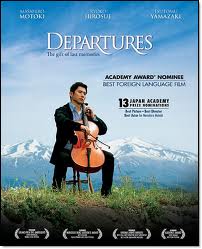Malattia, vecchiaia e morte, ecco gli indigesti ingredienti del film di Michael Haneke, Amour, vincitore della Palma d’oro al festival di Cannes 2012 e come miglior film straniero alla serata degli Oscar 2013. Haneke ha abituato il suo pubblico ad una durezza che spesso rasenta la crudeltà senz’anima, non è certo un indoratore di pillole, semmai al contrario è uno che ti rende le cose ancora più difficili da accettare e assorbire.
Malattia, vecchiaia e morte, ecco gli indigesti ingredienti del film di Michael Haneke, Amour, vincitore della Palma d’oro al festival di Cannes 2012 e come miglior film straniero alla serata degli Oscar 2013. Haneke ha abituato il suo pubblico ad una durezza che spesso rasenta la crudeltà senz’anima, non è certo un indoratore di pillole, semmai al contrario è uno che ti rende le cose ancora più difficili da accettare e assorbire.
In questo suo undicesimo lungometraggio ci troviamo di fronte ad una coppia di ottuagenari costretti ad affrontare la malattia vana, quella lenta e progressiva che non dà scampo e la morte pietosa.
Una compito fondamentale nella riuscita di questo film lo svolgono gli attori, Jean-Louis Trintignant (Georges) bravissimo, ma soprattutto una Emmanuelle Riva (Anne), addirittura straordinaria, che lascia letteralmente di stucco con la sua interpretazione. Inevitabile domandarsi come sia stato possibile non consegnarle l’oscar come migliore attrice, considerata anche la difficoltà del ruolo da impersonare. Una di quelle misteriose corrispondenze che governano il mondo ha voluto che la parola amour fosse presente nei due film più importanti ai quali abbia partecipato e che l’hanno fatta entrare nella storia del cinema. Riva ha infatti recitato anche nel famoso film di Resnais del 1959, Hiroshima mon amour che vanta la sceneggiatura di Marguerite Duras.
La scena iniziale poteva essere quella finale, un prologo che figura più da epilogo. I pompieri sfondano una porta chiusa e trovano il cadavere di una donna in decomposizione su un letto cosparso di fiori.
Musicisti in pensione, dopo una serata a teatro per il concerto di un ex allievo, l’indomani mattina, durante la colazione Anne ha un vuoto, rimane assente per alcuni minuti, e in quel momento in cui l’esistenza rimane sospesa inizia la fine, anzi è già finito tutto, perché niente sarà più come prima.
Perdita sì, ma anche assenza. Anne perde a poco a poco sé stessa fisicamente e di conseguenza la coscienza di sé, Georges recepisce questo vuoto che pian piano prende forma intorno a lui e comprende che non può rimpiazzarlo in alcun modo, così, anziché avvicinarsi alle persone, se ne allontana. I personaggi secondari svaniscono ad uno ad uno, la figlia già distante e superficiale, le infermiere inadeguate al compito da svolgere, i portinai troppo zelanti, sempre pronti a invadere la privacy rendendo qualche servizio superfluo. E poi c’è la dignità, un argomento così semplice eppure così spinoso. La dignità che dovrebbe essere qualcosa di squisitamente personale, privato, intimo al limite estremo, invasa dalla legge, dalla cultura religiosa, dall’elemento estraneo. Come si può dare dignità alla vita se non la si dà alla morte? Georges finirà per non rispondere più nemmeno al telefono, immergendosi in quella fredda desolazione che lo pone di fronte ad una scelta che non ha più niente a che vedere né con lui, né con la vita precedente. È un “qui e ora” inesorabile, privo di orpelli, definitivo.
 Il film segue passo passo il decadimento del corpo, prima l’interruzione, poi la paralisi del lato destro, poi l’allettamento, poi l’afasia, la parola trasformata in un grido, in un lamento continuo e il lento rattrappimento degli arti, ma si capisce anche che Anne comprende, che è prigioniera, rinchiusa in un corpo che non risponde ai comandi, è costretta a vivere la peggiore delle vite, la vita inutile. Quando ad esempio cerca di dire qualcosa alla figlia, facendo uno sforzo disumano, contorcendo i muscoli facciali solo per farfugliare quattro suoni incomprensibili ci si chiede davvero perché, perché si deve essere costretti a vivere?
Il film segue passo passo il decadimento del corpo, prima l’interruzione, poi la paralisi del lato destro, poi l’allettamento, poi l’afasia, la parola trasformata in un grido, in un lamento continuo e il lento rattrappimento degli arti, ma si capisce anche che Anne comprende, che è prigioniera, rinchiusa in un corpo che non risponde ai comandi, è costretta a vivere la peggiore delle vite, la vita inutile. Quando ad esempio cerca di dire qualcosa alla figlia, facendo uno sforzo disumano, contorcendo i muscoli facciali solo per farfugliare quattro suoni incomprensibili ci si chiede davvero perché, perché si deve essere costretti a vivere?
Il titolo inizialmente doveva essere Ces deux-là, ma poi grazie alla brillante intuizione di una produttrice si è deciso di cambiarlo in Amour e per sottolineare quanto siano importanti i particolari, c’è una differenza così profonda tra i due titoli da modificare radicalmente l’approccio dello spettatore.
Amour non è solo l’amore di coppia, ma anche l’amore per la musica, per l’arte e l’amore per la parola, per i rituali quotidiani, per il piacere delle piccole cose come prepararsi un tè o leggere un libro. Il film parla della perdita dell’amore inteso in tutte quelle accezioni e lentamente, un’immagine dopo l’altra, ti toglie tutto, lasciando spazio solo ad uno spettatore immobile, al cospetto di se stesso, spoglio, senza nemmeno più la speranza, ma con una certezza definitiva, quella che l’uomo è sempre in perdita, comunque vadano le cose. Eppure qui l’amore è soprattutto nel gesto estremo di un uomo che ama sì la sua compagna di una vita, ma in particolare ama un altro essere umano, privato di tutte le peculiarità che lo rendono tale, costretto a vivere senza poter vivere. Quando la verità è così lampante e monumentale non si può che rimanere pietrificati.
D’altra parte c’è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui abbiamo impostato la nostra esistenza ovvero basandola sull’idea di essere eterni e negando la morte con una forza tale da dimenticare che fa parte integrante della vita, che ne è una sua componente specifica e inevitabile. Si nasce con la morte addosso.
Haneke ce lo ricorda in ogni immagine. La telecamera è spietata, si muove con accanimento sui corpi dei due anziani che deambulano con una certa difficoltà e poi sul cammino devastante della malattia di Anne. Lo scenario è un enorme appartamento parigino dal quale, fatta eccezione per una breve sortita a teatro, non ci si sposterà più. Qualcosa tuttavia manca, volutamente, ed è un certo tipo di emozione, quella che ti travolge, quella nella quale ti puoi immergere, immedesimarti ed esorcizzarla piangendo, perché vedi qualcosa che tanto capita sempre agli altri. Ma qui non funziona, perché questo è un film da subire, due ore angoscianti che riprendono il declino di un corpo e di due vite. Ciononostante è così intenso che ti entra dentro e lì rimane, te lo porti appresso l’indomani e nei giorni seguenti, forse perché non c’è alcuna stimolazione della fantasia o del vagheggiamento, forse perché non vieni trasportato in mondi immaginari o in una storia d’amore indimenticabile, forse perché invece si tratta proprio di te, del fatto che sei umano e quindi ti ammali, invecchi, muori.
In una intervista Trintignant, a proposito della freddezza voluta di Haneke, ha raccontato che il regista non voleva assolutamente che si piangesse e che addirittura quando in una scena particolarmente commovente Riva è stata sopraffatta dall’emozione ed ha pianto, lui ha fermato le riprese ed ha tagliato la scena. Secondo Haneke infatti non è l’attore che deve mostrare, ma è la telecamera che deve sorprendere la sua emozione. E qui l’amore è anche tra la cinepresa e gli attori.
Se la vita del singolo finisce, se la vita di coppia chiude la parabola, l’esistenza comunque continua, la scena finale ritrae, in quel vuoto immenso, la figlia della coppia, Eva (il nome non è certo un caso), unica presenza viva nell’assenza, tocca a lei continuare, così com’è prescritto dalle leggi della natura.
Maledetta umanità, povera umanità. Amour.