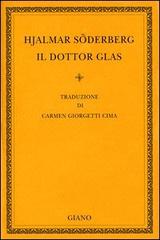«È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza…»
Un sogno all’interno di un altro sogno, forse. Il sogno della morte all’interno del sogno della vita. O meglio: il sogno della morte, unica realtà di una vita che è essa stessa solo un sogno. Primo Levi esprimeva quell’angoscia comune con una concisione inarrivabile. Niente era vero all’infuori del campo. Il resto, la famiglia, la natura in fiore, la casa, solo breve vacanza, inganno dei sensi.
 Jorge Semprún (1923-2011) è sopravvissuto ai campi di concentramento tedeschi, spagnolo di nascita, durante la guerra civile si rifugiò a Parigi e lì entrò a far parte della Resistenza antinazista, fu però catturato dalla Gestapo e, nel gennaio del 1944, deportato a Buchenwald come prigioniero politico. Ma si sopravvive davvero ad un’esperienza devastante come quella dei campi nazisti? Non credo che ci sia un termine adatto per descrivere chi è uscito “vivo” da quei luoghi dell’orrore, dove la stessa vita è diventata morte e il significato del linguaggio quotidiano è stato stravolto e ribaltato. Semprún crea La scrittura o la vita (1994) molti anni dopo la Liberazione e non si tratta del solito libro-cronaca di quei fatti terribili, ma di una riflessione profondissima che va al di là delle descrizioni, al di là degli eventi in sé, che si concentra su aspetti della natura umana e del pensiero che offrono una prospettiva ancora diversa rispetto a questo argomento sul quale forse pensiamo, sbagliando, che sia stato detto tutto il possibile.
Jorge Semprún (1923-2011) è sopravvissuto ai campi di concentramento tedeschi, spagnolo di nascita, durante la guerra civile si rifugiò a Parigi e lì entrò a far parte della Resistenza antinazista, fu però catturato dalla Gestapo e, nel gennaio del 1944, deportato a Buchenwald come prigioniero politico. Ma si sopravvive davvero ad un’esperienza devastante come quella dei campi nazisti? Non credo che ci sia un termine adatto per descrivere chi è uscito “vivo” da quei luoghi dell’orrore, dove la stessa vita è diventata morte e il significato del linguaggio quotidiano è stato stravolto e ribaltato. Semprún crea La scrittura o la vita (1994) molti anni dopo la Liberazione e non si tratta del solito libro-cronaca di quei fatti terribili, ma di una riflessione profondissima che va al di là delle descrizioni, al di là degli eventi in sé, che si concentra su aspetti della natura umana e del pensiero che offrono una prospettiva ancora diversa rispetto a questo argomento sul quale forse pensiamo, sbagliando, che sia stato detto tutto il possibile.
Ad Ascona, nel Ticino, in un giorno d’inverno pieno di sole, del dicembre del ’45, si era imposta una scelta: la scrittura o la vita. Ero stato io, certo, ad imporre a me stesso di fare quella scelta. Ero io, soltanto io, a dover scegliere. Il racconto che brandello su brandello, frase su frase, strappavo ai miei ricordi, come un cancro luminoso divorava la mia vita. O quantomeno il mio desiderio di vivere, di perseverare in questa misera gioia. Ero convinto di arrivare al limite in cui avrei dovuto prendere atto del mio fallimento. Non tanto perché non riuscivo a scrivere, quanto perché non riuscivo a sopravvivere alla scrittura.
Al contrario di molti prigionieri scampati alla morte che hanno sentito la necessità, per poter continuare a vivere, della scrittura, Semprún si concentra sulla politica, e dopo la Liberazione entra a far parte dei gruppi comunisti che combattevano contro Franco, è questa la sua spinta alla sopravvivenza. Ma negli anni Sessanta verrà espulso dal Partito Comunista e comincerà a sentire, sempre più pressante, l’esigenza di raccontare. Oltre ai libri si dedicherà all’attività di sceneggiatore e molti film verranno tratti dai suoi adattamenti, tra i registi più famosi con i quali ha lavorato figurano Alain Resnais e Konstantínos Costa-Gavras.
Avevo pensato che sarei potuto ritornare alla vita, dimenticare nella quotidianità della vita gli anni di Buchenwald, non tenerne più conto nelle conversazioni, con gli amici, e portare a termine comunque il progetto di scrittura che mi stava a cuore. Ero abbastanza presuntuoso da pensare che avrei potuto gestire quella concertata schizofrenia. Ma appariva chiaro che scrivere, in un cero senso, significava rifiutare di vivere. Ad Ascona, quindi, sotto il sole invernale, ho deciso di scegliere il silenzio frusciante della vita contro il linguaggio mortale della scrittura. Ne ho fatto una scelta radicale, era l’unico modo di procedere. Ho scelto l’oblio, ho messo in atto, senza troppa indulgenza nei confronti della mia identità, fondata essenzialmente sull’orrore – e forse sul coraggio – dell’esperienza del campo, tutti gli stratagemmi, la strategia, crudelmente sistematica, dell’amnesia volontaria.
Sono diventato un altro, per poter rimanere me stesso.
 Semprún ha scelto per lungo tempo di non raccontare, di non ricordare, di cancellare il periodo trascorso a Buchenwald come un insopportabile incubo da dimenticare, la sua voce è stata il silenzio. Quest’oblio volontario è durato per ben sedici anni. Ma si sa, quello che siamo prima o poi emerge sempre e la memoria è un processo che non conosciamo appieno, talvolta si svincola da ogni regola e segue un suo cammino che prescinde da quello che vogliamo. Così, come Proust intingendo la madeleine nella tisana di tiglio si accorge che un semplice sapore può fare riaffiorare ricordi apparentemente perduti, lo stesso processo di memoria involontaria avviene in Semprún attraverso il fumo di una sigaretta o il candore della neve che lo riportano all’improvviso nel campo. Nel 1961 lo scrittore era dirigente del Partito comunista spagnolo e per una settimana fu costretto a rimanere nascosto in un appartamento di Madrid senza mai uscire. Il padrone di casa era stato deportato a Mauthausen e non smetteva di raccontare la sua esperienza, ma Semprún si rendeva conto di come un racconto mal fatto non potesse dare minimamente l’idea di quello che era successo davvero. Alla fine della settimana ecco che si presenta anche per lui l’esigenza non più rimandabile di narrare quegli avvenimenti ed è così che prende forma Il grande viaggio (1963) dove si descrive il terribile itinerario di cinque giorni, insieme ad altri 119 detenuti ammassati all’interno di un vagone merci, diretto a Buchenwald. Nella genesi del romanzo La scrittura o la vita, invece è stato il suicidio di Primo Levi l’elemento scatenante della memoria.
Semprún ha scelto per lungo tempo di non raccontare, di non ricordare, di cancellare il periodo trascorso a Buchenwald come un insopportabile incubo da dimenticare, la sua voce è stata il silenzio. Quest’oblio volontario è durato per ben sedici anni. Ma si sa, quello che siamo prima o poi emerge sempre e la memoria è un processo che non conosciamo appieno, talvolta si svincola da ogni regola e segue un suo cammino che prescinde da quello che vogliamo. Così, come Proust intingendo la madeleine nella tisana di tiglio si accorge che un semplice sapore può fare riaffiorare ricordi apparentemente perduti, lo stesso processo di memoria involontaria avviene in Semprún attraverso il fumo di una sigaretta o il candore della neve che lo riportano all’improvviso nel campo. Nel 1961 lo scrittore era dirigente del Partito comunista spagnolo e per una settimana fu costretto a rimanere nascosto in un appartamento di Madrid senza mai uscire. Il padrone di casa era stato deportato a Mauthausen e non smetteva di raccontare la sua esperienza, ma Semprún si rendeva conto di come un racconto mal fatto non potesse dare minimamente l’idea di quello che era successo davvero. Alla fine della settimana ecco che si presenta anche per lui l’esigenza non più rimandabile di narrare quegli avvenimenti ed è così che prende forma Il grande viaggio (1963) dove si descrive il terribile itinerario di cinque giorni, insieme ad altri 119 detenuti ammassati all’interno di un vagone merci, diretto a Buchenwald. Nella genesi del romanzo La scrittura o la vita, invece è stato il suicidio di Primo Levi l’elemento scatenante della memoria.
Ricordare però è stato come consegnare la vita al mondo effimero dell’illusione, come se la morte e il male fossero divenuti una costante interrotta solo provvisoriamente dal sogno di vivere.
«Crematoio, spegnete!»[…]
Così, dopo il ritorno da Buchenwald, nei soprassalti del risveglio, o del ritorno in sé, ci capitava di sospettare che la vita non fosse stata altro che un sogno, a volte piacevole. Un sogno da cui quelle due parole ci risvegliavano d’improvviso, gettandoci in un’angoscia strana per la sua serenità. Poiché non era la realtà della morte, d’improvviso ricordata, ad essere angosciante. Era il sogno della vita, seppure sereno, ricco di piccole gioie. Era il fatto di essere vivi, seppure nel sogno, che era angosciante.
Vivere la morte, fare esperienza dell’unica cosa che non si può sperimentare, ovvero morire appunto. Per Semprún non si pone nemmeno l’ostacolo del linguaggio, secondo lui non esiste infatti l’indicibile, ma semmai l’invivibile. Allora il punto fondamentale non sta nella forma, ma nella sostanza, ed è proprio questa l’essenza che non è trasmissibile.
Si può sempre dire tutto insomma. L’ineffabile di cui tanto si parla è solo un alibi. O un segno di accidia. Si può sempre dire tutto, il linguaggio contiene tutto. Si può dire l’amore più intenso, la crudeltà più tremenda. Si può nominare il male, il suo gusto soporifero, i suoi piaceri deleteri. Si può dire Dio e non è poco. Si può dire la rosa e la rugiada, lo spazio di un mattino. Si può dire la tenerezza, l’oceano custode della bontà. Si può dire l’avvenire e i poeti vi si avventurano con gli occhi chiusi e la bocca feconda.
Sì si può dire tutto, ma è un tutto che riguarda la pienezza filologica, una ripetizione infinita di orrore e morte che però non riesce a far emergere anche il resto. Il racconto si può fare, ma quello che Semprún vuole ottenere è qualcosa di più, è la possibilità di esprimere anche tutto quello che sta dietro alle parole e che non appartiene al codice linguistico.
L’essenziale? Sì, credo di saperlo. Credo di cominciare a saperlo. L’essenziale è riuscire ad andare oltre l’evidenza dell’orrore per tentare di raggiungere la radice del Male radicale.
Perché l’orrore non era il Male, o almeno non era la sua essenza. L’orrore non era altro che l’addobbo, l’ornamento, l’apparato. L’apparenza insomma. Si sarebbero potute passare delle ore a fornire testimonianze sull’orrore quotidiano, senza sfiorare l’essenziale dell’esperienza della vita nel campo. Anche se si fosse testimoniato con un’assoluta precisione con una costante oggettività – per definizione negata al testimone individuale – anche in quel caso si sarebbe perso l’essenziale. Perché l’essenziale non era l’orrore accumulato, di cui potremmo elencare all’infinito i particolari. Si potrebbe raccontare una qualunque giornata, a cominciare dal risveglio alle quattro e mezzo del mattino, fino all’ora del coprifuoco: il lavoro massacrante, la fame perenne, la continua mancanza di sonno, le angherie dei kapo, le corvè delle latrine, gli schläge delle SS, il lavoro alla catena nelle fabbriche belliche, il fumo del crematoio, le esecuzioni pubbliche, gli interminabili appelli sotto la neve degli inverni, lo sfinimento, la morte dei compagni, senza con questo toccare l’essenziale, né svelare il mistero glaciale di questa esperienza, la sua tetra scintillante verità: la tenebra che ci era toccata in sorte. Che è toccata all’uomo come sorte, fin dall’eternità. Meglio ancora, fin dalla storicità.
«L’essenziale», dico al tenente Rosenfeld, «è l’esperienza del Male. Certo, la si può fare dappertutto, questa esperienza. Non c’è bisogno dei campi di concentramento per conoscere il Male. Ma qui sarà stata cruciale e totale, avrà invaso e divorato ogni cosa… è questa l’esperienza del Male radicale…»
La sostanza qui è il Male, non il racconto delle azioni supportate da una crudeltà senza limiti, ma proprio il fondamento immorale che porta alla negazione dei principi fondamentali dell’umanità, e che, al tempo stesso, fa parte integrante dell’essere umano che racchiude in sé l’umano e l’inumano, è questo forse il punto inaccettabile, il fatto che non ci si può opporre al Male assoluto, né negarlo come qualcosa che non appartenga alla specie umana, poiché ne è parte integrante.
La guerra è certamente il terreno più fertile per dare libero sfogo all’inumanità dell’umanità e l’uomo che recepisce, gli artisti, i poeti, si fanno carico di un dolore impotente, diventano anche portavoce, educatori, coloro che sono chiamati a trasmettere la conoscenza, la totalità dell’essere umano e l’inconcepibile vicinanza tra bene e male, animato e inanimato, vita e morte, tanto che, a ben guardare, a volte sembra proprio che non ci sia alcuna differenza.
Sono una creatura
Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
La morte
si sconta
vivendo
(G. Ungaretti)