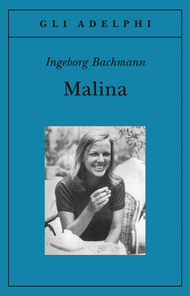La vita, a me, è solo passata davanti, senza fermarsi.
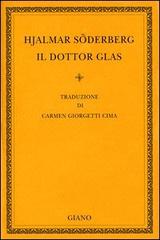 Un libro sul diritto, sul dovere e sulla volontà, sulla dannosa ricerca della verità, ma anche un giallo con tanto di delitto perfetto. Il dottor Glas (1905) all’epoca dell’uscita fece scandalo e non è difficile da credere dati i tanti temi scabrosi, imbarazzanti, audaci che tratta, anticipando anche l’eroe maledetto novecentesco che campeggerà alcuni anni dopo. Hjalmar Söderberg (1869-1941) scrittore svedese, fu costretto ad allontanarsi dalla Svezia due anni dopo la pubblicazione dell’opera, aveva raggiunto la notorietà all’età di 26 anni con il romanzo Smarrimenti (1895) per il quale fu accusato di pornografia e nel 1906 scriverà anche una pièce teatrale, Gertrud, dalla quale il famoso regista Carl Dreyer trarrà il film omonimo nel 1964.
Un libro sul diritto, sul dovere e sulla volontà, sulla dannosa ricerca della verità, ma anche un giallo con tanto di delitto perfetto. Il dottor Glas (1905) all’epoca dell’uscita fece scandalo e non è difficile da credere dati i tanti temi scabrosi, imbarazzanti, audaci che tratta, anticipando anche l’eroe maledetto novecentesco che campeggerà alcuni anni dopo. Hjalmar Söderberg (1869-1941) scrittore svedese, fu costretto ad allontanarsi dalla Svezia due anni dopo la pubblicazione dell’opera, aveva raggiunto la notorietà all’età di 26 anni con il romanzo Smarrimenti (1895) per il quale fu accusato di pornografia e nel 1906 scriverà anche una pièce teatrale, Gertrud, dalla quale il famoso regista Carl Dreyer trarrà il film omonimo nel 1964.
Assassinio, incompatibilità sessuale, aborto, eutanasia, l’inutile moralità, sono gli argomenti principali di cui parla all’interno del suo diario il dottor Glas, un giovane medico di Stoccolma che, stanco di seguire unicamente il pensiero, decide che per lui è finalmente arrivato il momento dell’azione.
Non ho mai visto un’estate così. Caldo canicolare fin da metà maggio. Tutto il giorno una densa foschia di polvere incombe immobile sopra le strade e le piazze.
All’insegna dell’afa, del caldo asfissiante che ottunde il pensiero e toglie la lucidità inizia questo viaggio in un delirio ragionato, dove ogni problema viene messo a fuoco e diventa semplicemente una causa naturale che l’usanza poi trasforma in violazione della moralità. Ciò che è semplice e genuino diventa complicato e inarrivabile a causa di leggi etiche che ne impediscono l’evolversi, azioni che potrebbero risollevare le sorti di vite miserevoli vengono negate dalla giustizia.
Diritti e Doveri.
Il pastore Gregorius è un prete viscido, che Glas trova ripugnante, tanto da desiderare di vederlo morto o addirittura di ucciderlo egli stesso. Gregorius ha sposato una donna avvenente e molto più giovane di lui, sulla quale “ha dei diritti” (anche quando si trasformano in violenza sessuale) e di contro lei “ha dei doveri” coniugali nei confronti del marito, perché così vuole l’abitudine, così detta la legge. Parlare di incompatibilità sessuale all’epoca era uno scandalo, l’ipocrisia imponeva il silenzio su argomenti scabrosi che andavano sepolti sotto quintali di sabbia. Ma di certo non è negando qualcosa che la si fa smettere di esistere e Söderberg mette in risalto la debolezza di certe convinzioni, minando addirittura le fondamenta stesse della moralità:
Caro amico, la morale, lo sai quanto me, si trova allo stato fluido. Ha subito cambiamenti rimarchevoli perfino negli istanti fugaci che noi due abbiamo trascorso sulla terra. La morale è quel famoso cerchio di gesso intorno alla gallina: limita chi ci crede. […]
La morale fa parte degli utensili domestici, non è una divinità. Deve essere utilizzata, non deve dominare. E la si deve adoperare con discernimento, cum grano salis. È saggio far proprie le usanze di dove si va; è sciocco farlo con convinzione. Io sono un viaggiatore nel mondo; guardo le usanze degli uomini e scelgo ciò che mi può servire. E morale viene da mores, usanze; si basa esclusivamente sul costume, sull’uso; non ha altri fondamenti.
 E cos’è in effetti questa morale sbandierata ai quattro venti se non il solito frutto delle convenzioni millenarie che affliggono l’umanità? La morale cambia in continuazione e per giunta con il supporto delle leggi umane e di quelle divine. Bastano pochi esempi, come ricordare che ai tempi delle leggi razziali antisemite delle azioni profondamente immorali, almeno per uno spirito libero che rispetta se stesso e quindi anche gli altri, erano rese lecite, anzi dovute per legge appunto, e come dimenticare che negli Stati Uniti, presunta patria della democrazia e della libertà, solo negli anni ’60 si è messo un freno al proliferare di leggi che di fatto escludevano chi non era caucasico dai diritti civili, compreso il matrimonio misto. Per sciocchezze simili, di cui non si aveva colpa un’enorme fetta di umanità ha sofferto e continua a soffrire, è morta e continua a morire, beffata anche dal supporto di una cosiddetta morale becera e gretta che offende qualsiasi cervello evoluto.
E cos’è in effetti questa morale sbandierata ai quattro venti se non il solito frutto delle convenzioni millenarie che affliggono l’umanità? La morale cambia in continuazione e per giunta con il supporto delle leggi umane e di quelle divine. Bastano pochi esempi, come ricordare che ai tempi delle leggi razziali antisemite delle azioni profondamente immorali, almeno per uno spirito libero che rispetta se stesso e quindi anche gli altri, erano rese lecite, anzi dovute per legge appunto, e come dimenticare che negli Stati Uniti, presunta patria della democrazia e della libertà, solo negli anni ’60 si è messo un freno al proliferare di leggi che di fatto escludevano chi non era caucasico dai diritti civili, compreso il matrimonio misto. Per sciocchezze simili, di cui non si aveva colpa un’enorme fetta di umanità ha sofferto e continua a soffrire, è morta e continua a morire, beffata anche dal supporto di una cosiddetta morale becera e gretta che offende qualsiasi cervello evoluto.
Gregorius incarna dunque l’ipocrisia sociale, è la metafora di tutte quelle leggi anche non scritte che si basano su usi e consuetudini che si perdono nella notte dei tempi.
Il rispetto per la vita umana – cos’altro è sulla mia bocca se non una squallida ipocrisia, e cos’altro può essere per chi di tanto in tanto abbia trascorso un momento libero a pensare. Il mondo brulica di vite umane. E nessuno, forse con l’eccezione di qualche filantropo davvero ridicolo, ha mai dato seriamente il minimo peso a vite umane estranee, sconosciute, ignorate. Lo dimostrano i fatti. Tutti i governi e i parlamentari del mondo lo dimostrano.
Quando un’anima si mette a nudo, l’esoscheletro che mantiene in piedi di fronte alla società può anche afflosciarsi in un angolo della coscienza. Così il dottor Glas, tra le pagine del suo diario può dire esattamente ciò che pensa su qualsiasi argomento. La disquisizione principale verte sui diritti e i doveri che la società impone a prescindere dalla volontà e dall’ideologia del singolo. Ad esempio al medico capitava periodicamente di ricevere suppliche da parte di donne per interrompere una gravidanza indesiderata, ed ecco che lui era costretto a sciorinare la consueta tiritera sul rispetto della vita umana e sul dovere, per poi confessare alle pagine del diario il suo vero pensiero e la sua codardia nel rifiutare l’aiuto richiesto solo per evitare spiacevoli conseguenze. Glas si rende conto che il rispetto per la vita umana è solo una facciata ipocrita, in quanto medico sa bene ad esempio che la civiltà di un popolo si misura principalmente sul diritto alla morte, ad una morte dignitosa.
Verrà il giorno – deve venire – in cui il diritto di morire sarà riconosciuto come un diritto dell’uomo, ancora più importante e più incontestabile di quello di mettere un pezzo di carta nell’urna elettorale. E quando il tempo sarà maturo, ogni malato incurabile avrà diritto all’aiuto del medico, se desidera la liberazione.
Volontà.
A questo punto si pone l’interrogativo fondamentale e cioè si può uccidere qualcuno solo perché ci ripugna e perché fa soffrire l’essere amabile e gentile che gli vive accanto? Può la volontà mutare il destino? l’atto voluto può compiersi al di là delle leggi morali? Fino a che punto si può volere qualcosa?
Volere – già che cosa significa? La volontà di una persona non è un tutt’uno; è la sintesi di cento impulsi contrastanti. Una sintesi è una finzione. La volontà è una finzione. Ma noi abbiamo bisogno di finzioni e nessuna finzione ci è più necessaria della volontà. Perciò vuoi davvero? […]Perché vuoi? Rispondi! «Io voglio agire. La vita è azione. Quando vedo qualcosa che mi indigna, voglio intervenire.»
Glas porta in sé la tipologia dell’eroe decadente in lotta contro il mondo e le convenzioni che limitano il pensiero, lontano dalle impetuose ribellioni degli eroi romantici, mantiene sempre una sorta di freddezza originata probabilmente dal profondo disprezzo verso le regole, che pure deve seguire, suggellate come un voto indelebile dal giuramento di Ippocrate.
Non devi fare domande! Non andare al fondo delle cose: perché allora tu stesso andrai a fondo. Non cercare la verità: non la troverai e perderai te stesso. Non devi fare domande! La misura di verità, che ti può servire, ti viene data in dono; è mescolata con illusione e menzogna, ma è per il tuo bene, allo stato puro ti brucerebbe le viscere. Non cercare di ripulire la tua anima dalla menzogna, sarebbe seguita da talmente tante cose cui non avevi pensato, e tu perderesti te stesso e tutto ciò che ti è caro. Non devi fare domande!
A furia di inseguire le proprie inquietudini ci si accorge di quanto tutto si trasformi in illusione. A che vale sottoscrivere delle regole se poi queste possono essere violate e rimanere impuniti? Della facciata conformista se si viola la superficie non rimane niente. Ogni azione è un atto di volontà che prescinde da diritti, doveri, moralità, giustizia. E i conti alla fine si fanno unicamente con la propria coscienza, ammesso che se ne abbia una, e per metterla a tacere potrebbe bastare smettere di interrogarsi, smettere di pensare.
Vita, io non ti capisco. Ma non dico che la colpa sia tua. Ritengo più probabile che sia io un figlio degenere, piuttosto che tu una cattiva madre.
E alla fine ha cominciato a sorgermi nella mente come un’intuizione che forse la vita non la si deve capire. Tutta questa smania di spiegare e di capire, tutta questa caccia alla verità è forse una strada sbagliata. Noi benediciamo il sole perché viviamo proprio alla distanza da esso che ci è più vantaggiosa. Qualche milione di miglia più vicino o più lontano e bruceremmo o geleremmo. E se per la verità fosse come per il Sole?
L’antico mito finnico dice: colui che vede il volto di dio deve morire. E Edipo. Lui sciolse l’enigma della Sfinge e divenne il più misero tra gli uomini.
Non risolvere enigmi! Non fare domande! Non pensare! Il pensiero è un acido che corrode. All’inizio pensi che distruggerà solo ciò che è marcio e malato e deve essere tolto. Ma non è così che la pensa il pensiero: esso distrugge alla cieca. Comincia con la preda che tu gli getti più volentieri e con più gioia, ma non credere che possa saziarlo. Non smetterà finché non avrà rosicchiato l’ultima cosa che hai cara.
Il confine tra giusto e sbagliato è effimero, la storia lo dimostra e la quotidianità ce lo insegna, del resto, dopo la soffocante afa, non rimane che aspettare l’autunno e poi l’inverno per seppellire sotto una coltre di neve l’estate delle passioni.
E presto verrà la neve. La neve si avverte nell’aria.
Sarà la benvenuta. Che venga. Che cada pure.